Nel panorama digitale attuale, TikTok è diventato un punto di riferimento per chi cerca risposte rapide, anche su temi complessi come la salute mentale. L’ADHD è uno degli argomenti più discussi sulla piattaforma, spesso attraverso video personali che raccontano sintomi, difficoltà quotidiane e percorsi di consapevolezza. Ma quanto sono affidabili queste testimonianze?
Un recente studio pubblicato su PLOS ONE e condotto da Vasileia Karasavva, dottoranda in psicologia clinica presso l’Università della British Columbia, ha analizzato i 100 video più popolari su TikTok con l’hashtag #ADHD. I risultati sollevano dubbi sulla qualità dell’informazione disponibile. Solo la metà delle affermazioni sui sintomi era in linea con i criteri ufficiali del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5). Il resto? Un miscuglio di interpretazioni personali, generalizzazioni o semplici esperienze comuni etichettate come segnali clinici.
Sintomi comuni o vere diagnosi?
Tra le affermazioni più diffuse ma non supportate dalla letteratura scientifica ci sono comportamenti come urtare spesso i mobili, ascoltare ripetutamente la stessa canzone o avere una forte preferenza per i dolci. Sintomi che, secondo i due psicologi clinici coinvolti nello studio, non rientrano nei criteri diagnostici dell’ADHD, ma vengono presentati online con una sicurezza che rischia di disorientare chi è in cerca di risposte. Il problema non è solo la mancanza di accuratezza, ma l’assenza di sfumature. Solo il 4% dei video analizzati ha chiarito che i sintomi descritti non si applicano universalmente a tutti coloro che hanno ricevuto una diagnosi. Ancora meno hanno ricordato che anche persone senza ADHD possono sperimentare quegli stessi comportamenti.
Il potere della ripetizione
La fiducia che molti utenti ripongono in questi contenuti è alimentata dalla frequenza con cui vengono proposti. Studi sulla disinformazione mostrano infatti che l’esposizione ripetuta a certe affermazioni può renderle credibili, anche se mancano di fondamento. In un contesto dove l’accesso a uno psicologo è spesso limitato da costi, attese e burocrazia, TikTok diventa un rifugio. Ma è un rifugio imperfetto. Molti creatori di contenuti sembrano animati da buone intenzioni. Eppure, l’algoritmo della piattaforma premia brevità, immediatezza e coinvolgimento, caratteristiche che mal si adattano a una narrazione scientificamente rigorosa. A peggiorare il quadro, la metà dei video più visti promuoveva prodotti, servizi o chiedeva donazioni, creando un ulteriore motivo per diffondere messaggi semplici e d’impatto, anche se inesatti.
Le difficoltà di chi cerca una diagnosi
Per chi sospetta di avere l’ADHD, il consiglio resta quello di rivolgersi a un esperto. Ma Karasavva stessa ammette quanto questo percorso possa essere difficile, soprattutto per chi presenta proprio le caratteristiche che rendono complesso affrontare un iter diagnostico: disorganizzazione, difficoltà di attenzione, fatica nel sostenere un processo lungo e spesso costoso. A tutto questo si aggiunge una questione sistemica. I criteri diagnostici sono stati a lungo modellati sulla base di come l’ADHD si manifesta nei bambini maschi bianchi. Donne e persone appartenenti a minoranze etniche restano ancora oggi sottodiagnosticate. Il sospetto verso il sistema sanitario, quindi, non è infondato. Come sottolinea Karasavva: “Non mi fido del sistema perché il sistema non è stato creato per me” è un pensiero legittimo per molte persone.
La risposta della piattaforma
Interpellata sui risultati dello studio, TikTok ha risposto sottolineando il proprio impegno nel fornire accesso a contenuti affidabili:
“Mentre le persone si esprimono in modo autentico e creano comunità di supporto su TikTok, forniamo in modo proattivo alla comunità di TikTok l’accesso a informazioni affidabili sulla salute mentale dalla Cleveland Clinic, dal National Institute of Mental Health e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”, ha scritto un portavoce della piattaforma in un’e-mail inviata a Scientific American.
Un sistema che va ripensato
Fino a quando l’accesso alla salute mentale non sarà più equo e realmente disponibile, i social continueranno a essere uno dei principali punti di riferimento. Ma senza strumenti critici, c’è il rischio che quel che nasce come un percorso di consapevolezza si trasformi in un percorso confuso, segnato da diagnosi fai-da-te e autoetichettature fuorvianti.
“Nulla cambierà se il sistema non cambia e non diventa più accessibile alle persone che hanno bisogno di supporto”, conclude Karasavva.











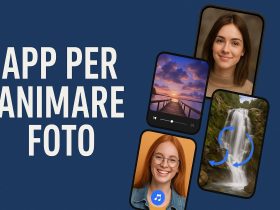








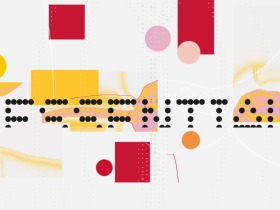









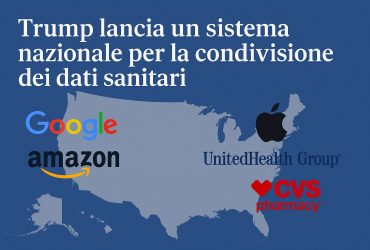




Lascia un commento